di Alessandra Vescio
21.07.2021
Tempo di lettura 12'
Illustrazione © Giulia Rosa
Il 16 giugno 2021 il TG3 ha diffuso il video che mostra l’incidente avvenuto alla funivia del Mottarone lo scorso 23 maggio e che ha provocato la morte di 14 persone. Si tratta di immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza e depositate agli atti, che fanno parte dunque di un’indagine che di suo aveva già fatto discutere molto, tra un’inusuale apertura da parte della Procura nei confronti della stampa e la sostituzione della giudice per le indagini preliminari.
In seguito alla diffusione del video da parte del TG3, altre testate e redazioni hanno pubblicato quelle stesse immagini sui loro siti web, in televisione o sui canali social. Da quel momento, chiunque avesse acceso la TV o aperto il proprio profilo Facebook o Twitter si sarebbe potuto ritrovare davanti un video violento che spiega sì la dinamica dell’incidente ma che al tempo stesso mostra volti, dolori, intimità e morti.
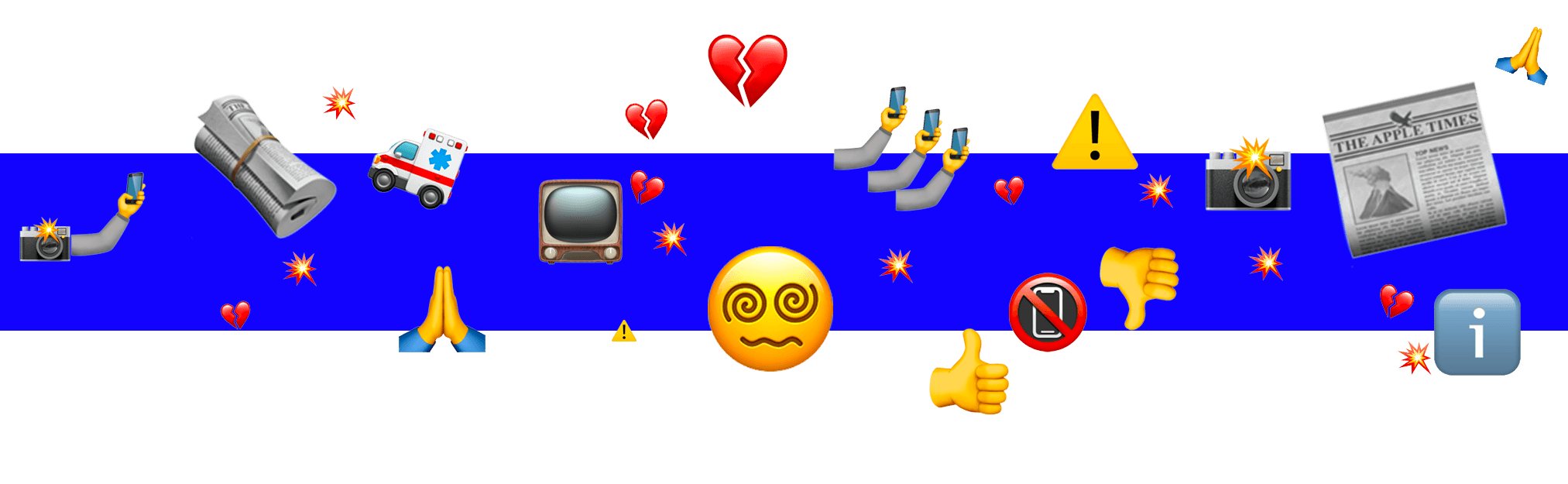
La scelta di pubblicare questo video è stata fortemente criticata dall’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali che ha invitato “i media e gli utenti dei social network ad astenersi dall’ulteriore diffusione delle immagini e da forme di spettacolarizzazione dell’evento, che possono solo acuire il dolore dei familiari delle vittime e di quanti erano loro legati”.
Quelle immagini infatti non erano state viste neppure dalle famiglie delle persone che in quell’incidente avevano perso la vita.
Una reazione aspra e critica è arrivata anche dagli utenti che hanno riconosciuto nella condivisione di quel video un’invasione della privacy e una totale mancanza di rispetto per un momento così tragico, dettato nella maggior parte dei casi dal desiderio di giornali e redazioni di attirare l’attenzione, incrementare l’audience e indurre gli utenti a cliccare sui loro siti web. Non è un segreto infatti che il mondo dell’informazione oggi sia ampiamente in crisi e che molto sia dovuto alla difficoltà delle testate di adattarsi all’avvento del web e dell’informazione online, con un conseguente impatto negativo sugli introiti.
Attualmente, il principale modello di business di moltissimi giornali online è legato alla pubblicità, alle visualizzazioni e ai click su banner e video promozionali presenti sulle pagine web dei giornali: si parla di pochi centesimi di euro per ogni visualizzazione, per cui risulta necessario accumulare quanti più accessi al sito possibili nell’ottica di garantirsi un (minimo) guadagno. Da questa esigenza derivano le gallerie fotografiche di celebrities in costume, i titoli esagerati e sensazionalistici (conosciuti anche come “clickbait”, ovvero “acchiappa-click”), la condivisione di video e immagini di momenti tragici che sarebbero dovuti rimanere privati.
Solo pochi giorni prima della diffusione del video dell’incidente alla funivia del Mottarone, un altro episodio particolarmente intimo e doloroso era diventato oggetto di sciacallaggio da parte di molti media, soprattutto italiani. Sabato 12 giugno, infatti, durante la partita degli Europei tra Danimarca e Finlandia, il calciatore danese Christian Eriksen ha avuto un arresto cardiaco. Immediatamente i compagni e i medici lo hanno soccorso, salvandogli la vita. Non solo, i giocatori danesi lo hanno anche accerchiato, per proteggerne la privacy e tutelare il dolore che quel momento portava con sé. Non è bastata però l’intenzione dei compagni, dal momento che su diverse testate sono stati prontamente pubblicati i video di Eriksen che si accascia a terra, le foto di lui che perde coscienza, ma addirittura le immagini della moglie in lacrime, il tutto accompagnato da titoli ad effetto che stuzzicavano una morbosa curiosità.
Non è purtroppo una novità, anzi. Il sensazionalismo più macabro sui media viene solitamente raggiunto nel racconto di quelli che vengono definiti come fatti di cronaca nera.
Omicidi, femminicidi, violenze sono spesso raccontati non in maniera attenta e rispettosa delle vittime, eventualmente analizzandone le motivazioni strutturali, quanto piuttosto andando a fondo nei dettagli più intimi e cruenti, generando una vera e propria “pornografia del dolore”.
Sappiamo ad esempio che Noemi Durini, vittima di femminicidio, è stata trovata con “il cranio sfondato e il volto irriconoscibile”, ma poco è stato detto sulle cause di sistema che hanno provocato questa violenza di genere. Ci sono stati raccontati nel dettaglio gli stupri avvenuti nel 2017 sulle spiagge di Rimini. Abbiamo addirittura assistito al momento in cui alla madre di Sarah Scazzi è stato annunciato il ritrovamento del corpo della figlia. I giornali e le televisioni ci hanno abituato a considerarci parte di drammi familiari, spettatori curiosi e giudici puntuali di processi mediatici, senza alcun rispetto e cura delle vittime e dei loro cari.
Eppure esistono delle carte e delle regole che hanno lo scopo di tutelare la dignità delle persone sui media. Una di queste è il Testo unico dei doveri del giornalista che, nell’articolo 8, riporta che “Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell´immagine”. Sebbene qualche redazione sostenga che il ruolo del giornalismo sia quello di dare sempre le notizie, qualunque esse siano, ammantando così di professionalità quella che invece sembra più semplicemente un’ossessiva ricerca di spettacolarizzazione del dolore altrui, è in realtà proprio la rilevanza sociale ciò su cui ogni giornalista dovrebbe interrogarsi, soprattutto quando è in dubbio se pubblicare o meno del materiale particolarmente cruento.
Nel 2018, ad esempio, il New York Times scelse di pubblicare la foto di una bambina denutrita in prima pagina sulla propria testata: un’azione assolutamente di impatto e che costrinse chiunque avesse avuto sotto gli occhi il quotidiano statunitense a fare i conti con quella foto e la storia che si portava dietro. L’intento del New York Times era quello di denunciare l’orrore della guerra in Yemen e questa decisione è stata così motivata: “Questo è il nostro lavoro di giornalisti: di offrire testimonianze, di dare voce a chi altrimenti sarebbe abbandonato, vittimizzato e dimenticato”. È lì il nodo centrale della questione, in quel “dare voce” a chi altrimenti non l’avrebbe, a chi non viene ascoltato, a chi – con le sole parole – non verrebbe creduto.
Per questo motivo, sono risultate essenziali le immagini del corpo massacrato di Stefano Cucchi, quelle che ritraggono le violenze sui detenuti a Santa Maria Capua Vetere, il video dell’uccisione di George Floyd. Perché sono immagini che hanno fatto emergere ciò che altrimenti sarebbe rimasto sotterrato e taciuto, nel silenzio doloroso di vite oppresse.
Ben diverso, invece, è il discorso che può emergere dal video di un incidente mortale che può essere senza alcun dubbio e più semplicemente raccontato in maniera magistrale e rispettosa da parte di un giornalista, perché osservare, capire, raccontare è parte del suo lavoro. Non lo è invece sfruttare una tragedia per tornaconti personali e profitti aziendali.
[Continua sotto]
Quando nel 2010 ad Haiti scoppiò un’epidemia di colera in seguito al terremoto, molti giornali internazionali e soprattutto americani ricoprirono la notizia tramite immagini, video e reportage anche abbastanza crudi. Questo approccio generò un’attenzione importante sui fatti avvenuti ma, come emerse molto presto, la prospettiva da cui venne raccontata l’epidemia risultò piuttosto paternalistica: il colera era descritto come “una semplice conseguenza della terribile o devastante condizione di povertà in cui versava lo Stato, senza un minimo di contesto o indagine”.
Per molte redazioni, dunque, non era tanto importante fare luce su ciò che stava accadendo, provando a inquadrarne le cause, quanto scavare il più possibile dentro un evento che si era trasformato in una vera e propria miniera d’oro per i media, perché attirava l’attenzione delle persone e nutriva quell’intimo desiderio di osservare i dolori degli altri.
Come ha spiegato Claude Gills della ONG Reporters without Borders, infatti, «la copertura ha aumentato la visibilità, ma senza la componente morale della responsabilità nei confronti degli abitanti di Haiti nel lungo periodo, si tratta semplicemente di sfruttamento». «È risaputo», continua Gills, che «il sangue, il sesso e la violenza vendano». E i giornali oggi hanno un disperato bisogno di vendere.
L’attrazione verso ciò che è macabro, ripugnante, misterioso è un tratto tipico degli esseri umani, che la filosofia, la psicologia e la letteratura indagano da sempre. Nel suo saggio Storia della bruttezza, Umberto Eco racconta il significato e le manifestazioni che il brutto in senso ampio ha assunto nel corso dei secoli e gli effetti che esso ha sulle persone. Citando il filosofo Shiller, infatti, l’autore parla del “fascino irresistibile” che ciò che è orrendo ha su di noi, e di come siamo respinti e attratti al tempo stesso da “scene di dolore e di terrore”. “È in questo spirito”, scrive Eco, che è nato ad esempio il romanzo gotico, con i suoi “sotterranei terrorizzanti”, i “sanguinosi delitti”, i “corpi decomposti”. I media però hanno tutto un altro ruolo sociale, non fanno letteratura e anzi bisognerebbe chiedersi piuttosto quanto sia opportuno che provino ad assecondare questo istinto primordiale. Di certo, come vari studi stanno dimostrando, questo approccio morboso sta avendo delle conseguenze psicologiche importanti.
Sembra infatti che una continua esposizione alla brutalità possa avere diversi effetti sulla psiche umana, da una maggiore aggressività alla desensibilizzazione nei confronti della violenza stessa.
Quest’ultimo caso può riguardare sia chi lavora con le notizie sia chi le riceve. Nel settembre 2015, ad esempio, diverse testate internazionali hanno condiviso la foto di Alan Kurdi, un bambino di origini siriane morto dopo un naufragio davanti alla coste turche. È un’immagine terribile e scioccante, che però è stata consapevolmente condivisa da molti giornali perché considerata fondamentale per fare luce sulla reale situazione della guerra in Siria e sulle condizioni dei migranti. A non condividere quella foto fu il quotidiano francese Liberation, che ne ha poi raccontato il motivo. L’immagine non venne pubblicata non perché considerata troppo forte, non perché la redazione non fosse interessata al tema della guerra in Siria e delle migrazioni, ma perché – più semplicemente – quella foto non era stata vista. Probabilmente, si legge sul quotidiano francese, i giornalisti avevano visto talmente tante foto di bambini migranti morti in mare che l’immagine di Alan Kurdi non ha rappresentato nulla di nuovo, nulla di straordinario ai loro occhi.
Per quanto riguarda invece i lettori, le lettrici e gli utenti che ricevono le notizie, sarebbe opportuno che le redazioni si interrogassero sia su cosa rendere pubblico ma anche su come farlo, perché non tutti sono in grado di reggere immagini di violenza e brutalità. A questo proposito, una strategia interessante è quella adottata dal New York Times, che non si tira mai indietro nel pubblicare immagini e video anche impressionanti se considerati rilevanti a livello sociale e politico, ma che lo fa solo sulla propria testata e mai sui propri canali social. Il quotidiano statunitense sostiene infatti che chi compra e sceglie il New York Times è consapevole di ciò che potrebbe trovare. Sui social network, invece, non si ha il controllo sulle notizie e le immagini che si incontrano sul feed, per cui un utente potrebbe ritrovarsi costretto a vedere qualcosa che avrebbe preferito evitare e che potrebbe avere un impatto negativo sul proprio benessere psicofisico. Un’altra modalità valida è l’utilizzo di disclaimer e trigger warning, che segnalano la presenza di elementi disturbanti e che invitano dunque l’utente a compiere una scelta consapevole nel continuare o meno a leggere, guardare o ascoltare una certa notizia.
Per la capacità che il giornalismo ha di influenzare le persone e la società, è riduttivo e parziale sostenere che il suo ruolo sia quello di dare sempre le notizie a prescindere da quali esse siano, così come è svilente trasformarlo in una piazza del dolore per motivi di profitto e necessità di catturare e trattenere quanto più possibile l’attenzione delle persone.
È fondamentale, piuttosto, chiedersi sempre (e farlo con totale onestà) se una data foto o un dato video possano aggiungere davvero qualcosa in più o di essenziale alla notizia che si sta dando, qualcosa per cui le parole potrebbero non bastare. Le notizie vanno date, certo, purché però tutelino le persone coinvolte e chi quelle notizie potrebbe recepirle, perché non possiamo lasciarci sfuggire che l’umanità e il rispetto vengono prima di tutto il resto.



La newsletter di K Magazine che racconta i trend, a strati.
Ho letto e compreso le informazioni riguardanti il trattamento dei miei dati personali illustrate nella Politica sulla privacy e accetto di ricevere comunicazioni commerciali tramite questa newsletter o altri mezzi utilizzati dall'editore.